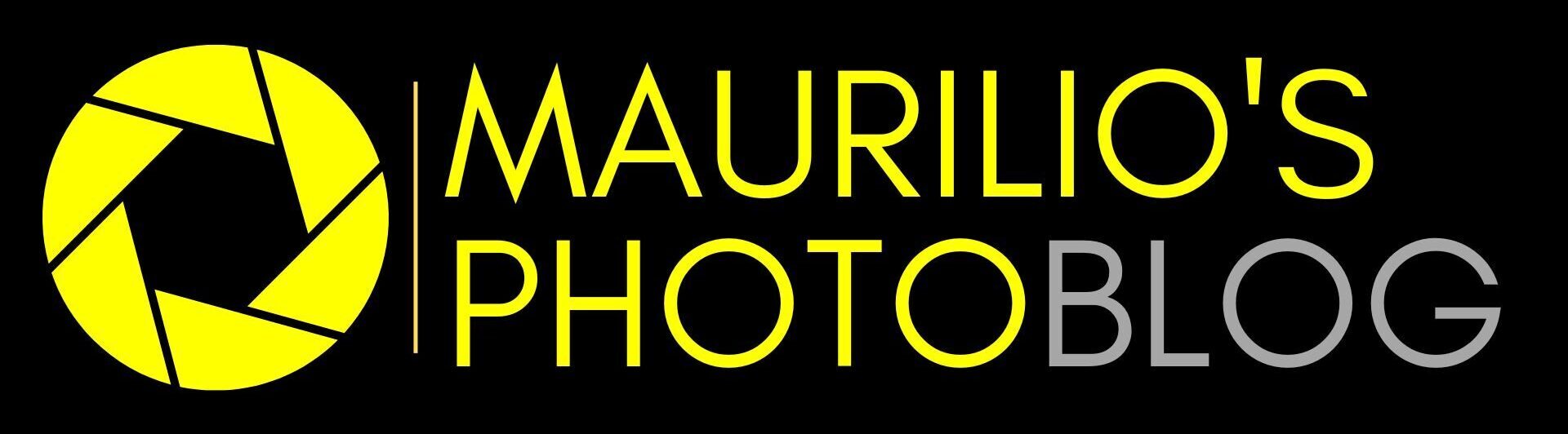Diane Arbus
New York 1923 – 1971
Diane Arbus è considerata un maestro della fotografia del XX secolo.
Nasce in una famiglia ebrea molto benestante di origine polacca. Nata Diane Nemerov, a 18 anni sposa il fotografo Allan Arbus che lavorava per l’azienda di moda di pellicce della famiglia. Inizia la sua carriera collaborando con le principali riviste di moda come Vogue, Glamour e Harper’s Bazaar.
Nel 1957 si separa dal marito. Inizia un percorso artistico personale per il quale riceve una borsa di studio dalla Fondazione Guggenheim.
La fotografia di Diane Arbus cambia radicalmente con connotazioni più contemporanee.
Inizia ad esibire forti contrasti e illuminazioni ottenute anche con il flash. Bisogna considerare che l’uso del flash non era molto popolare all’epoca, soprattutto nella fotografia artistica.
Lentamente, mette da parte la fotografia in studio e si immerge nella vita e nei luoghi popolari di New York. La città offre un’ispirazione insolita, ricca di personaggi bizzarri, emarginati e freaks che diventano l’ossessione della Arbus e con i quali lo spettatore è costretto a stabilire un legame intimo.
Durante la sua lunga formazione come fotografa di moda cresce come professionista nel rigore formale e nella perfezione tecnica. In seguito, tuttavia, la Arbus vi rinuncerà volentieri.
Alla fine degli anni Cinquanta, inizia la sua ricerca personale che reagisce alla falsificazione cosmetica della realtà borghese.
Uscendo dallo studio, si immerge per catturare immagini di una realtà che non aveva mai fotografato, ambienti e atmosfere di cui all’epoca una giovane borghese benestante non può che avere paura.
I tempi erano giusti.
Con gli esponenti della beat generation che rifiutavano i modelli della vita borghese americana e l’estetica pop che ne coglieva invece l’essenza di perfezione costruita ispirata dalla pubblicità per la società dei consumi. La Arbus sceglie invece di schierarsi più apertamente e di cercare attivamente un coinvolgimento privato con il suo soggetto. La sua macchina fotografica è priva di veli e di trucco, lontana dalle mode, senza giudizio e contro ogni moralismo.
Questo le varrà il costante disprezzo dei benpensanti, ma anche il continuo sostegno e incoraggiamento di amici fotografi e intellettuali.
Alcune Note Tecniche
I soggetti particolari di Diane Arbus sono una costante della sua maturità artistica.
Affascinata dal film “Freaks” del 1932, va a incontrare le sfortunate vittime di deformità congenite e gli individui eccentrici, che ritrae preferibilmente nelle loro case e camere da letto. In questi casi fa largo uso del “medio formato” che, a partire dal 1962, ha totalmente rivoluzionato la sua fotografia.
La tecnica non è fine a se stessa, ma serve a soddisfare le sue nuove esigenze espressive. Infatti, i soggetti scelti e l’onestà nel ritrarli richiedono chiarezza d’immagine e definizione dei dettagli. L’assenza di giudizio e le esigenze narrative che si esprimono nel dramma impongono un’inquadratura quadrata e simmetrica e soggetti posti frontalmente al centro della fotografia.
Diane Arbus ha ammirato e studiato il lavoro di August Sander, con le sue composizioni classiche in cui le persone ritratte guardavano l’osservatore, in piedi al centro di uno sfondo sobrio. Ma è stata anche attenta all’insegnamento di Lisette Model, per la quale, tuttavia, la fotografia doveva essere uno strumento di indagine. Invece, la Arbus opta piuttosto per uno scambio di emozioni tra fotografo e fotografato. La fotografia non è ricerca, non è virtuosismo tecnico: è una connessione.
Quindi, mentre le immagini scattate in gioventù sono ovattate e armoniose, con il tempo Diane Arbus adotta i forti contrasti dei flash in esterni, sia di notte che di giorno.
Fino agli anni ’60 Arbus ha utilizzato una Nikon 35 mm per poi passare a un medio formato 6×6, prima una Rolleiflex biottica, poi una Mamiya C33, e dal ’70 anche una Pentax 6×7.
Nelle sue opere troviamo sempre il rapporto diretto di uno sguardo rivelatore, che probabilmente ottiene (oltre che con la sua, da molti testimoniata, innata capacità di mettere a proprio agio le persone) anche grazie alla carica non aggressiva del tipo di attrezzatura fotografica che utilizza: le sue macchine fotografiche con mirino all’altezza della vita non sono invadenti e aggressive, e la fotografa, a testa china, non mette in soggezione il soggetto, guardandolo direttamente come lo scienziato che scruta attraverso un microscopio. Questo tipo di macchina è un confine psicologico.

Dopo il suo suicidio per depressione (spesso sopravvalutato nel giudicare il suo lavoro fotografico), è stata la prima tra i fotografi americani a essere ospitata dalla Biennale di Venezia nel 1972; e il MOMA ha ospitato una grande retrospettiva nello stesso anno.